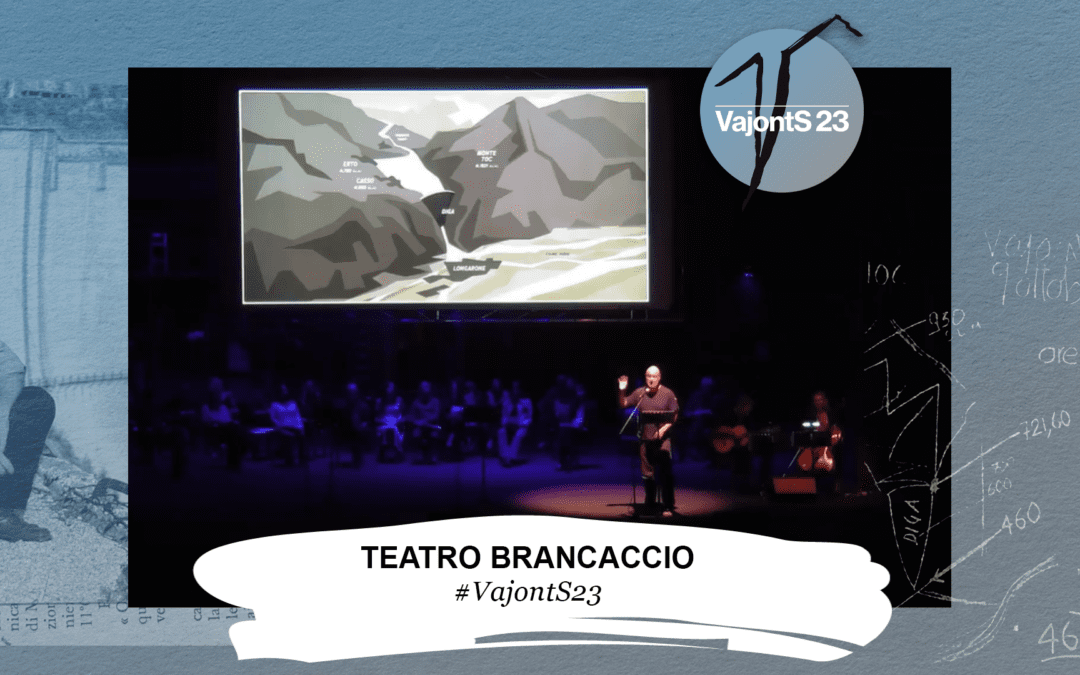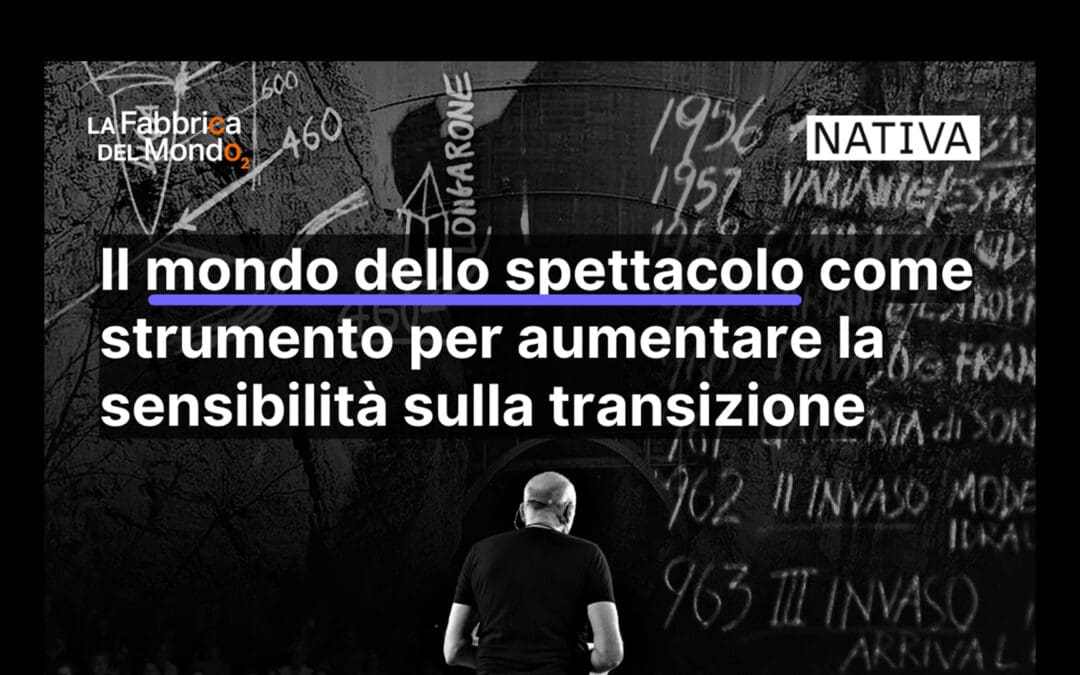Provo un racconto di ciò che è stato per me
Io, quel giorno, ero a casa con la febbre. Non è mai successo nella mia vita che io non sia andata in scena – nemmeno il giorno in cui è morto mio padre – e non è mai successo che io non sia stata presente a un debutto; eppure, il 9 ottobre io non c’ero. Sono stata alla televisione a guardare – ancora una volta – il monologo di Marco; io l’ho visto, sulla diga del Vajont; e in questi due mesi l’ho consultato spesso, per capire alcune frasi, alcuni punti, non è stata una passeggiata questo Vajonts 23, ho dovuto cercare capire una montagna di cose. Quando mi è stato consegnato il testo, la prima volta ho tagliato alcuni pensieri che non coglievo, poi ho riaperto i tagli e alla fine ho solamente sintetizzato, ma, come sempre, ho rispettato le parole, specie quelle importanti.
Il lavoro principale che ho fatto è stato di dare una connotazione a ogni singola voce, e a ogni singolo attore, perché per me il teatro è uno spazio altro, in cui si ricrea il reale, abitato da creature viventi come noi, in cui forse è possibile aprire nuove strade utili per il mondo di qua.
Il giorno prima dello spettacolo, dopo la filata, che era la prima pur essendo l’ultima (il giorno dopo era già la generale) ero un po’ avvilita, ho pensato che gli attori stessero facendo fatica ad uscire da se’, li ho trovati un po’ leggeri… distratti da altre cose… poco a fuoco, insomma (ma so di essere, generalmente, fino all’ulOmo, piu-osto incontentabile). Ho fatto due ore di note e poi sono andata a bere una birra con Michele Tonicello, il mio provvidenziale aiuto.
Sono stati due mesi di grande lavoro, in cui posso dire di aver fatto tutto ciò che era in mio potere… ma quella sera ho temuto che il racconto non avrebbe passato la linea di boccascena. Per cui la mattina, quando ho realizzato che il mio corpo era arrivato, che mi teneva per i capelli e mi diceva “stai a casa”, ho sentito che questa situazione poteva anche essere interessante, nella sfiga: insomma, adesso la responsabilità era tutta nelle loro spalle e se la dovevano assumere, finalmente!
A fine spettacolo mi ha telefonato Luca Casaroli, il direttore di palcoscenico, per farmi sentire gli applausi… tanti… diceva che il teatro era gonfio… poi mi arrivano dei messaggi, toccanti, pieni di emozione, commozione, come se il pubblico si fosse sentito parte del senso profondo di questa storia, come se avesse chiuso il cerchio… sono stata felice.
Questo penso sia stato anche il succo della visione di Marco e de La Fabbrica del Mondo, quando hanno elaborato questa idea così rischiosa e coraggiosa, così ispirata: raccogliere “pezzi” del teatro italiano intorno a un discorso politico, che ci riguarda tutti.
Ma come si fa a preparare uno spettacolo in tre giorni? Non si può. Gli attori non sono orchestrali, che arrivano con la parte studiata – mica sempre però – e quando si trovano pensano solo a sintonizzarsi col direttore, per farla come la vuol fare lui, tutti insieme… Gli attori sono abituati ad altri ritmi, hanno bisogno di digerire il lavoro più a lungo e soprattutto hanno bisogno di provare dal vivo, con il regista, con gli altri attori… eppure…
eppure l’abbiamo fatto lo stesso, questo spettacolo.
Ho cominciato a lavorare sul testo a fine luglio, e me lo sono portato in vacanza, dove ho lavorato tenacemente per adattare il testo – senza inventare nemmeno una parola o quasi – ad ogni singolo attore della compagnia che mi è stata proposta; affidando a ciascuno di essi un tema, un colore specifico, un “ruolo”; cercando di tirare fuori la persona che sta dietro la parola… o meglio direi dentro la parola; cercando di comprendere concretamente, fisicamente, in prima persona, una vicenda compiuta da uomini come noi; e forse così poter prospettare, dal di dentro, una via d’uscita, per il futuro di tutti: il teatro come regno del possibile.
Sono fiduciosa del fatto che il teatro possa dare un contributo a un nuovo umanesimo, nel mondo di qua; un mondo che perde costantemente sensibilità, attenzione: all’ambiente, ai simili, alle altre specie viventi; che perde il rapporto con il non conosciuto, con l’indicibile, con il mistero, che in definitiva mi pare il tema centrale di questa storia, e di “Vajonts 23” oggi, nel presente.
Ho consegnato il testo agli attori un mese prima, perché lo studiassero… una mossa un po’ ingenua, devo dire… ma non importa. Non avendo mai lavorato con gran parte di loro, li ho voluti incontrare prima, ad uno ad uno; con tutti ho letto e analizzato il testo di riferimento, con tutti ho bevuto almeno un bicchiere di qualcosa.
In scena c’erano:
Laura Babaian, Margherita ScoW, Daniele Capitani , SebasOan Dassi, Mosé Baechtold, Greta Nola, giovani allievi dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, il coro propriamente detto; Maria Roveran, la corifea. Il pensiero è stato quello di consegnare loro – che nel 1963 non erano ancora nati – tutte le battute che tracciano le linee filosofiche del racconto e che guardano al futuro, al futuro del pianeta, in comunicazione diretta col pubblico, con la possibilità di essere mobili nello spazio; Carlo D’ Alpaos e Giorgio Puste-o, alias Carlo &Giorgio, due comici molto popolari, che hanno interpretato se’ stessi, aggiudicandosi buona parte delle battute comiche, tenendo sempre la complicità col pubblico, facendo anche un’incursione in platea nella descrizione del fiume Piave e del porto operoso;
Ottavia Piccolo, Luciano Roman, Giacomo Rossetto, Eleonora Fuser, Anna Tringali, Gianmarco Busetto, attori magnifici e d’esperienza, che hanno portato la storia e incarnato i suoi protagonisti: gli ingegneri, i geologi, i tecnici, i giornalisti, gli amministratori, la gente della valle, la montagna stessa, la frana; tenendo sempre una certa mobilità in scena, una presenza corporea oltre che vocale;
uno spazio teatrale, che conteneva un semicerchio di leggii, aste microfoniche, monitor, cubi neri; uno spazio del racconto e dell’ascolto, abitato da parole, suoni, azioni, luce; uno spazio paesaggio che ho immaginato essere la stessa valle del Vajont.
Questa riunificazione artistica e civile che La Fabbrica del Mondo ha avuto il coraggio di immaginare è stato un momento raro e prezioso e si colloca in un panorama teatrale disunito e frammentato. Ha aperto la speranza che il teatro possa essere ancora il luogo deputato in cui la cittadinanza si incontra e produce pensiero, oltre che poesia e bellezza. A Venezia, il pubblico in sala non era il solito: c’erano un sacco di persone che a teatro non ci vanno più. Ho pensato di desiderare fermamente un teatro per un pubblico attivo, che viene per capire qualcosa, per sentire qualcosa, non per starsene sulla poltrona ad annoiarsi o in attesa del miracolo, ma per stringersi in un cerchio di con –passione, e poi portarsi a casa qualcosa: nuove idee, comportamenti, nuove percezioni di se’, della società, dell’ambiente…
Forse quella sera è andata così o almeno mi piace pensarlo.
Sono consapevole di aver partecipato a un progetto unico e importante. Quando mi sono ammalata, si, mi è spiaciuto immensamente non poter fare gli ultimi ritocchi, e alla fine sedermi in sala a godermi questo momento; ma nello stesso tempo so di aver fatto tutto quanto era nelle mie capacità per onorare questa giornata, questa storia, questa gente di montagna e i morti del Vajont. Da allora, guardo le rocce in un altro modo, assisto ai disastri con maggior angoscia, capisco che tutto nasce dalle nostre scelte, ho un grande desiderio di essere presente.
Un ringraziamento a tutto lo staff tecnico e organizzativo del Teatro Stabile del Veneto e del Teatro Goldoni.
P.s. Questo lavoro, mi piacerebbe portarlo avanti
Sandra Mangini – regista – teatro Goldoni – Venezia